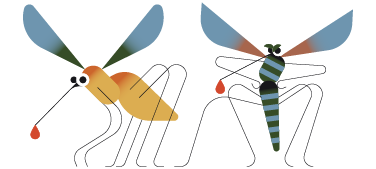Piretrine e piretroidi: un rischio per la salute umana?(3/3). Effetti sugli adulti
L’esposizione ai piretroidi può causare diverse sintomatologie acute, come allergie, dispnea, irritazione delle vie respiratorie, broncospasmo, nausea, tremore, vomito, sindrome di salivazione, aumento della temperatura interna, coreoatetosi (ISPRA 2015; Hołyńska-Iwan e Szewczyk-Golec 2020; EEA 2023).
Gli effetti di lungo termine comprendono patologie neurocomportamentali, disturbi del neurosviluppo, sindromi riproduttive con implicazioni nella infertilità maschile, danni al sistema immunitario e al sistema endocrino (Saillenfait et al. 2015; Andersen et al. 2022; Curtis et al. 2023; Oyovwi, et al. 2025).
L’International Agency for Research on Cancer (IARC) classifica la deltametrina, la permetrina e il fenvalerate nel gruppo 3 (non classificabili come cancerogeni per l’uomo)[1], mentre l’Environmental Protection Agency (EPA) considera i piretroidi come “verosimilmente cancerogeni per l’uomo” (in ISPRA 2015).
I piretroidi possono entrare nell’organismo per inalazione, ingestione di alimenti e acqua contaminati o per contatto cutaneo. I gruppi più vulnerabili sono i bambini, gli operatori professionali e le persone che ne fanno uso in modo improprio, spesso inconsapevoli delle precauzioni necessarie (ISPRA 2015; EEA 2023).
I piretroidi possono interagire nei sistemi endocrini mimetizzando, bloccando o sinergizzando gli effetti degli ormoni endogeni (Leemans et al. 2019). È stato osservato, inoltre, che il principale metabolita dei piretroidi, l’acido 3-fenossibenzoico, aumenta il rischio di morte per malattie cardiovascolari nella popolazione adulta degli Stati Uniti d’America e influenza il livello degli ormoni tiroidei nelle donne in gravidanza (Bao et al. 2020. Va segnalato che la normativa sull’impiego dei piretroidi è più restrittiva nell’Unione Europea rispetto agli Stati Uniti (in ISPRA 2015).
Nelle formulazioni in commercio i piretroidi sono spesso associati al piperonil butossido, un sinergizzante che inibisce la detossificazione del citocromo P-450, e che potrebbe interferire anch’esso con alcuni processi neurologici (Andersen et al. 2022).
In conclusione, piretro e piretroidi non sono sostanze innocue per la salute umana, animale e ambientale: interagendo con le numerose sostanze tossiche presenti nel nostro ambiente, contribuiscono ad aumentare il rischio di sviluppare malattie.
Per maggiori approfondimenti si rimanda ai seguenti riferimenti bibliografici:
- Andersen H.R., et al. 2022. Pyrethroids and developmental neurotoxicity - A critical review of epidemiological studies and supporting mechanistic evidence. Environ. Res. 214: 113935.
- Bao W., et al. 2020. Association between exposure to pyrethroid insecticides and risk of all-cause and cause-specific mortality in the general US adult population. JAMA Intern. Med. 180: 367–374.
- Curtis M.A., et al. 2023. Developmental pyrethroid exposure causes a neurodevelopmental disorder phenotype in mice. PNAS Nexus. 2, 1–12. https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad085pgad085.
- EEA. 2023. How pesticides impact human health and ecosystems in Europe. https://www.eea.europa.eu/publications/how-pesticides-impact-human-health/how-pesticides-impact-human-health/download.pdf.static.
- Hołyńska-Iwan I, Szewczyk-Golec K. 2020. Pyrethroids: How they affect human and animal health? Medicina (Kaunas). 56(11):582. doi:10.3390/medicina56110582.
- ISPRA. 2015. Impatto sugli ecosistemi e sugli esseri viventi delle sostanze sintetiche utilizzate nella profilassi anti-zanzara. Quaderni - Ambiente e Società 10/2015, 222 pp.
- Leemans M., et al. 2019. Pesticides with potential thyroid hormone-disrupting effects: a review of recent data. Front Endocrinol. 10:743. https://doi.org/10.3389/fendo.2019.00743.
- Oyovwi M.O., et al. 2025. Implication of pyrethroid neurotoxicity for human health: a lesson from animal models. Neurotox Res. 43, 1. https://doi.org/10.1007/s12640-024-00723-1.
- Saillenfait A.-M., et al. 2015. Pyrethroids: exposure and health effects–an update. Int. J. Hyg. Environ. Health 218: 281–292.
[1] Nella classificazione IARC il Gruppo 3 comprende sostanze non classificabili in relazione alla loro cancerogenicità per l’uomo. Questa categoria è usata per agenti per i quali l’evidenza di cancerogenicità è inadeguata nell’uomo e inadeguata o limitata nell’animale da esperimento. Sono classificati in questo gruppo gli agenti che non ricadono in nessun’altra categoria. Il Gruppo 4 invece è la categoria utilizzata per agenti per i quali c’è evidenza suggestiva di assenza di cancerogenicità sia nell’uomo, sia nell’animale da esperimento.